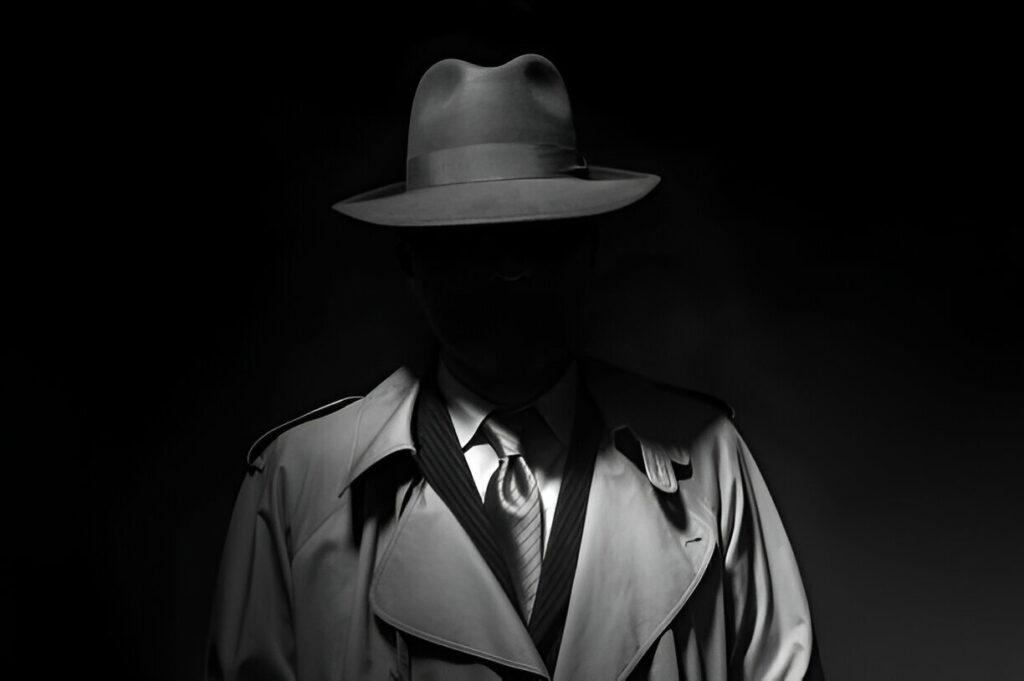Le mafie non sono più quelle delle immagini stereotipate di violenza e controllo del territorio. Negli ultimi decenni si sono trasformate in potenze economiche globali, capaci di infiltrarsi nei settori strategici dell’economia e di gestire flussi finanziari con strumenti sofisticati. Questa metamorfosi le ha rese più difficili da individuare e contrastare. Oggi operano come vere e proprie multinazionali del crimine, muovendo miliardi di euro con discrezione e sfruttando la tecnologia per consolidare il proprio potere.
Se un tempo il loro dominio si basava sul controllo fisico del territorio, oggi preferiscono investire nell’economia legale, gestire appalti pubblici e influenzare il consenso sociale. I loro volti non sono più quelli dei boss di strada, ma quelli di imprenditori, manager e professionisti che siedono nei consigli di amministrazione e investono in settori chiave come energia, sanità e infrastrutture.
L’Economia mafiosa
Non solo violenza: le mafie comprano, corrompono e investono. Gestiscono interi comparti economici, ottenendo appalti pubblici e infiltrandosi nelle istituzioni. Secondo EUROPOL, il giro d’affari illecito generato dalla criminalità organizzata in Europa ammonta a 110 miliardi di euro all’anno. In Italia, il fatturato mafioso supera i 150 miliardi, una cifra superiore al PIL di Paesi come Ungheria o Slovacchia, rendendo le organizzazioni criminali la “prima azienda” del Paese.
Il potere economico delle mafie non si limita all’Italia: i loro capitali fluiscono senza ostacoli nei mercati internazionali, approfittando di paradisi fiscali e reti di investimento opache. Attraverso prestanome e società di copertura, reinvestono il denaro in attività apparentemente lecite, aumentando la loro influenza nel sistema economico globale.
Il motore: droga e riciclaggio
Il traffico di droga rimane la principale fonte di ricchezza delle mafie. La cocaina, con rotte che attraversano America Latina, Africa ed Europa, garantisce una liquidità inarrestabile. Nel 2023, nei porti italiani sono state sequestrate oltre 130 tonnellate di cocaina, per un valore di 6 miliardi di euro, pari all’intero bilancio annuale di alcune Regioni italiane.
I proventi del narcotraffico vengono poi riciclati in attività lecite, contribuendo a rendere le mafie sempre più invisibili. Hotel di lusso, catene di ristoranti, cliniche private e locali notturni sono solo alcuni dei settori in cui il denaro sporco viene reinvestito. Milano, Londra e Zurigo rappresentano le principali piazze di riciclaggio, dove i clan operano con strategie sempre più sofisticate, rendendo difficile l’intervento delle autorità.
Tecnologia e consenso
Le mafie dominano il cyberspazio, sfruttando criptovalute, il dark web e piattaforme digitali per facilitare il riciclaggio di denaro e il traffico di droga. Ma il vero salto di qualità è avvenuto nella costruzione del consenso. Attraverso i social network, TikTok e Instagram in primis, diffondono una narrazione seducente della criminalità, facendo apparire il modello mafioso come sinonimo di potere e successo.
Influencer, cantanti neomelodici e video virali contribuiscono alla normalizzazione di questa cultura, trasformando i boss in icone di ricchezza e ribellione. Un’indagine di Transcrime ha rivelato che il 45% dei giovani segue influencer legati alla criminalità organizzata, un dato allarmante che evidenzia il rischio di una progressiva accettazione dell’ideologia mafiosa.
Contrastare questa propaganda è fondamentale. Servono strategie mirate: campagne di sensibilizzazione nelle scuole, maggiore vigilanza sulle piattaforme digitali e un ruolo più attivo delle istituzioni nel promuovere modelli alternativi di successo. Solo con un’azione congiunta sarà possibile smontare il fascino della cultura mafiosa e impedire che le nuove generazioni ne diventino complici inconsapevoli.
La risposta dello Stato: una battaglia invisibile
Negli ultimi anni, le Forze dell’ordine hanno inferto colpi durissimi alle mafie. L’arresto di Matteo Messina Denaro nel 2023, dopo trent’anni di latitanza, ha rappresentato una svolta storica nella lotta a Cosa Nostra. Parallelamente, operazioni di grande rilievo hanno colpito la criminalità organizzata in diverse regioni italiane: a Secondigliano e Caivano, la polizia ha ripreso il controllo di quartieri storicamente segnati dalla camorra, mentre in Sicilia, solo pochi giorni fa, un blitz ha portato all’arresto di 181 affiliati a potenti clan mafiosi.
Ma contrastare il crimine organizzato non può essere solo compito delle istituzioni: è una responsabilità collettiva. Finché le mafie saranno viste come un problema distante o, peggio, come un male inevitabile, continueranno ad avere spazio per prosperare. Serve un cambiamento radicale nella percezione del fenomeno, basato sulla consapevolezza e sull’educazione alla legalità.
Solo attraverso un impegno condiviso tra Stato, cittadini e media sarà possibile spezzare questa rete invisibile che soffoca il Paese e restituire alla società il controllo su un’economia e una cultura libere dalla morsa della criminalità organizzata.