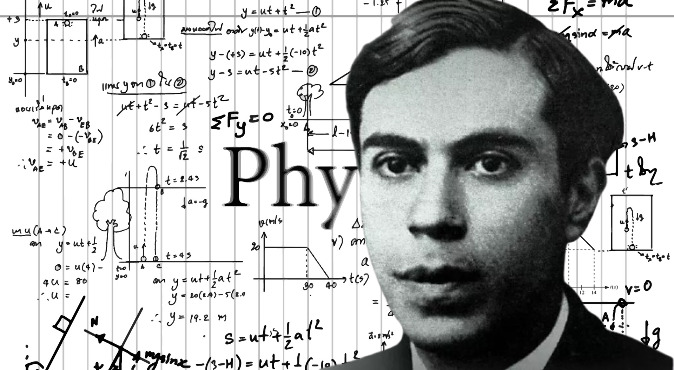Quale fu il contributo di Ettore Majorana alle scoperte di fisica atomica? Cosa si nasconde dietro il mistero della sua scomparsa? Fu suicidio o fuga? Enrico Fermi, suo maestro e amico, ha sempre considerato Majorana «un genio come Galileo o Newton»: perché allora Majorana si è sempre rifiutato di rivelare ad altri o di pubblicare le sue teorie?
Nelle cronache dimenticate degli ultimi settant’anni forse non c’è pagina più densa di incognite, di interrogativi senza risposta, del cosiddetto caso Majorana.
Roma, 30 marzo 1938: Bocchini, il capo della polizia fascista, viene convocato personalmente da Mussolini, da cui riceve un importante incarico: ritrovare Ettore Majorana.
Ma chi è questo Majorana?, si sarà chiesto probabilmente il capo della polizia. Sulla scrivania del duce c’è una lettera del più giovane Accademico d’Italia, il fisico Enrico Fermi: «Non esito a dichiarare che, fra tutti gli studiosi italiani e stranieri, Majorana è quello che per profondità d’ingegno mi ha maggiormente colpito. Egli possiede al massimo grado quel raro complesso di attitudini che formano il fisico teorico di gran classe».
Il professor Orso Mario Corbino l’aveva definito «il primo fisico d’Europa» quando Majorana aveva appena compiuto ventiquattro anni.
Nato a Catania il 5 agosto 1906, Ettore Majorana aveva dimostrato sin da piccolo di possedere un’intelligenza prodigiosa: a cinque anni calcolava a mente quanto carbone avrebbe bruciato una nave per compiere un certo viaggio. A sette vinse il titolo di campione provinciale di scacchi. A nove anni, nascosto sotto il tavolo del salotto, stupiva lo zio Quirino, docente di fisica, gridandogli il risultato delle estrazioni di radici cubiche che calcolava a memoria.
Nel 1926 Majorana frequentava l’ultimo anno di ingegneria al Politecnico di Roma. Un giorno l’amico e collega di studi, Emilio Segrè, che dal Politecnico era passato alla facoltà di fisica, cercò di trascinare a fisica anche Ettore: «Vieni» gli disse, «ti faccio conoscere Enrico Fermi. Sono certo che ti entusiasmerà». Fermi studiò a lungo e in silenzio Ettore, più giovane di lui di alcuni anni; gli parlò delle più recenti teorie della fisica e gli mostrò una complicatissima tabella di valori calcolata durante un ciclo di studi e di esperimenti. L’indomani Majorana tornò da Fermi. Gli chiese di vedere ancora la tabella dei valori, la confrontò con un foglietto di quaderno zeppo di cifre che aveva portato con sé, poi concluse: «Sì, li ha calcolati esattamente».
L’incontro tra Fermi e Majorana segnò l’inizio della collaborazione del giovane genio siciliano alle affascinanti ricerche che, con povertà di mezzi uniti alla ricchezza di ingegno e di entusiasmo, si conducevano nella Scuola di fisica di via Panisperna. Si sarebbero in seguito rivelati formidabili ricercatori, tenendo a battesimo le prime utilizzazioni dell’energia nucleare: si chiamavano Fermi, Segrè, Amaldi, Rasetti, Pontecorvo.
Nel laboratorio di via Panisperna, Majorana è l’unico che riesce a competere con Fermi. Un giorno si sfidarono a trovare la soluzione di un difficile problema. Fermi ha carta, penna e un regolo calcolatore, Majorana nulla: arrivano alla soluzione nello stesso tempo. Da allora in poi nessuno si prese più la briga di fare calcoli, bastava chiederli a Ettore.
La sua mente era un vulcano: in tram, per la strada, al ristorante, gli venivano in mente sempre nuove idee, soluzioni di problemi prima insoluti o spiegazioni di risultati provati sperimentalmente in laboratorio; allora si fermava di colpo, si frugava in tasca alla ricerca di un involucro di sigarette, di una scatola di cerini, di un biglietto del tram su cui scrivere formule complicate. Invano Fermi lo spingeva a pubblicare i suoi risultati e a malincuore ricordava di aver visto finire nel cestino della carta straccia, annotata sul solito pacchetto di Macedonia, la stessa teoria con cui, un anno più tardi, il tedesco Werner Heisenberg avrebbe vinto il premio Nobel. Ma del resto, anche quando nel 1957 i fisici cinesi naturalizzati americani, Lee e Yang, ottennero il Nobel per la loro teoria sulle particelle elementari, ci si accorse in ritardo che la stessa teoria era stata formulata trent’anni prima da Majorana.
Nel 1933 lo scienziato siciliano scrive per l’Accademia dei Lincei una teoria del nucleo atomico con cui ottiene una borsa di studio in Germania e in Danimarca, dove incontra Heisenberg e il grande Niels Bohr, patriarca della fisica atomica. Al suo rientro a Roma, Fermi lo incoraggia a proseguire quel filone di studi. È questo il periodo d’oro dei ragazzi di via Panisperna, che stanno sperimentando la produzione di radioattività artificiale mediante neutroni. Infatti, a partire dal fluoro, l’atomo di un dato elemento, colpito dai neutroni, emette radioattività e si trasforma nell’atomo dell’elemento successivo. Ma quando Fermi e i suoi ragazzi giungono a bombardare l’ultimo elemento esistente in natura, il novantaduesimo, cioè l’uranio, si trovano di fronte a un risultato addirittura sconcertante: anche l’uranio emette radioattività e si trasforma. In che cosa, se non esistono più elementi dopo il novantaduesimo?
Così Fermi comincia a pensare, sia pure con molte riserve, di aver prodotto o scoperto un nuovo elemento: il 93. Chi mette fine a ogni perplessità è Orso Mario Corbino, direttore dell’Istituto di fisica, che, ansioso di assicurare una «vittoria della scienza fascista», annuncia pubblicamente la scoperta dell’elemento 93. La notizia suscita immenso scalpore: fisici da ogni parte del mondo inviano a Roma le loro congratulazioni. Il solo Fermi continua a rimanere scettico.
Qualche mese più tardi il gruppo di via Panisperna compirà una seconda esperienza fondamentale, dimostrando — in una vasca di pesci rossi — che l’idrogeno è in grado di moltiplicare la produzione di radioattività: un principio su cui sarà basata, qualche anno dopo, la costruzione della prima pila atomica.
È proprio in questo periodo di successi che Majorana si isola dal gruppo, diventa scorbutico, intrattabile. La pubblicazione di alcuni suoi lavori gli ha procurato una meritata fama. Gli scrivono da tutto il mondo proponendogli cattedre: da Cambridge, da Yale, da Mosca, da Tokyo. Respinge la corrispondenza scrivendoci sopra: «respinto per decesso del destinatario».
Passa lunghi periodi chiuso nella sua stanza d’albergo: il suo migliore amico, Edoardo Amaldi, che va a trovarlo, è costretto a mandargli un barbiere. Sul suo tavolo, libri di economia politica, trattati sulla costruzione delle navi, libri di medicina, pagine di appunti gremiti di fitte formule e un romanzo di Pirandello: Il fu Mattia Pascal, storia di un uomo che tenta di cancellare la propria identità per costruirne un’altra.
Sempre nello stesso periodo, mentre il mondo scientifico continua a parlare dell’elemento 93, una studiosa tedesca avanza un’incredibile teoria: Fermi e i suoi ragazzi non hanno prodotto un nuovo elemento, ma hanno spaccato l’atomo di uranio, liberandone l’energia. La spiegazione, bocciata come inattendibile, rivelerebbe sconcertanti orizzonti: il controllo dell’enorme energia che lega intimamente le particelle dell’atomo, l’energia atomica.
È forse questa prospettiva a terrorizzare Majorana e a isolarlo dai suoi amici e dal mondo? Il suo comportamento è inconcepibile: sembra che, per qualche misterioso motivo, abbia il timore di rivelare il risultato dei suoi studi.
«La fisica è una strada sbagliata. Siamo tutti su una strada sbagliata» dirà più tardi, sul finire del ’37, al professor Carrelli.